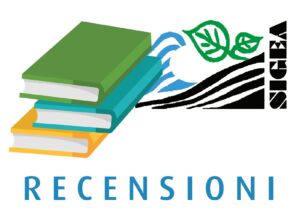
a cura di Giacomo Milazzo
Recensione
«Io però vedo una scienza che naviga, con sforzo e dedizione, tra la Cariddi di un’arroganza che presuppone che i nostri successi scientifici siano dovuti al fatto di aver strappato eroicamente alla natura i suoi segreti, e la Scilla della diffidenza, che ci spinge a dire che non sappiamo nulla e che dovremmo procedere sempre e solo con estrema cautela.»
«Il libro si intitola La scienza vista da una filosofa. Notate che è diverso da “La scienza vista dai filosofi” e da “La filosofia guarda alla scienza”. È una distinzione importante, perché i filosofi sono un gruppo eterogeneo, e nessuno di noi pensa la stessa cosa. Quello che vedo io guardando alla scienza non è quello che vedono “i filosofi”, né forse quello che vede la maggior parte dei filosofi, ma è quello che vedono molti di noi che osservano i dettagli della scienza per come viene praticata.» (Nancy Cartwright)

Il libro critica l’idea che tutti i fenomeni possano essere spiegati solo con le leggi fondamentali della fisica. L’Autrice sfida la supremazia della fisica, proponendo invece un sistema scientifico dinamico e interattivo, in cui nessuna disciplina prevale. Il saggio offre una visione alternativa e strumenti per interpretare criticamente il ruolo della scienza su temi come la crisi climatica, le nuove tecnologie e la ricerca medica. Ideale per chi è interessato alle implicazioni sociali e politiche della scienza.
L’Autrice mette in discussione tre idee comuni sulla scienza: la combinazione di teoria ed esperimento, la riducibilità alla fisica, e il determinismo. Il suo libro utilizza esempi dalle scienze fisiche, della vita e sociali, e analizza tutti i prodotti scientifici per rivelare cosa rende affidabile la scienza. Inoltre, sostiene che questa affidabilità è compatibile con una visione della natura reattiva al cambiamento umano. Invitando innanzi tutto ad una maggiore umiltà intellettuale nelle istituzioni scientifiche e nelle persone di scienza offre una rapida panoramica del suo punto di vista.
Storicamente, i filosofi hanno esaminato la scienza e osservato teorie audaci espresse in termini di leggi universali, sottoposte a esperimenti cruciali che confutano o corroborano le ipotesi teoriche. Hanno individuato una gerarchia disciplinare con la fisica come regina dominante sulle altre scienze, passando per la chimica, la biologia e infine le scienze sociali. Da questa immagine della scienza e delle sue teorie, hanno delineato un’immagine del mondo in cui, secondo le parole del filosofo Quine, «non succede nulla… non il battito di una palpebra, non il tremolio di un pensiero, senza una qualche ridistribuzione degli stati microfisici». Si ritiene che tale ridistribuzione sia interamente regolata da leggi fisiche deterministiche (o, nel caso dei fenomeni quantistici, indeterministiche). L’immagine risultante offre poco spazio per un’azione genuina o per spiegazioni autentiche di eventi oltre a quelle derivanti dalla fisica fondamentale. Data una configurazione iniziale degli stati microfisici e le leggi fisiche che ne governano l’evoluzione, tutto ciò che accade è conseguenza di queste condizioni e leggi iniziali.
 La filosofa, e ci tiene a sottolinare il punto di vista come filosofa, e quindi donna, presenta una visione completamente diversa della scienza. Sfida la concezione degli scienziati limitati alla produzione di teorie audaci e ai test sperimentali. Invece, vede una rete ricca e complessa di attività e metodi che aiutano a sviluppare concetti teorici, costruire modelli, creare narrazioni per comprendere il mondo e generare i fenomeni necessari per mettere in pratica e testare queste teorie. Analizzando specificamente la fisica sperimentale, l’Autrice prende ad esempio l’esperimento Stanford Gravity Probe B, un progetto da 750 milioni di dollari volto a testare la teoria della relatività generale di Einstein utilizzando giroscopi orbitanti. L’esperimento fu concepito nel 1959-60 e i lavori di progettazione iniziarono nel 1962. Le misurazioni furono effettuate nel 2004-05 e i dati analizzati vennero pubblicati nel 2011. Il lungo intervallo tra ideazione ed esecuzione è stato in parte dovuto al tempo necessario per sviluppare la tecnologia necessaria per le misurazioni, inclusa la produzione degli oggetti più rotondi al mondo: rotori giroscopici di quarzo così lisci che, se ingranditi alle dimensioni della Terra, la loro montagna più alta o la trincea più profonda non sarebbero più lunghe di due metri. La motivazione di tale levigatezza, secondo l’osservazione di Cartwright, è che le leggi della fisica impongono…
La filosofa, e ci tiene a sottolinare il punto di vista come filosofa, e quindi donna, presenta una visione completamente diversa della scienza. Sfida la concezione degli scienziati limitati alla produzione di teorie audaci e ai test sperimentali. Invece, vede una rete ricca e complessa di attività e metodi che aiutano a sviluppare concetti teorici, costruire modelli, creare narrazioni per comprendere il mondo e generare i fenomeni necessari per mettere in pratica e testare queste teorie. Analizzando specificamente la fisica sperimentale, l’Autrice prende ad esempio l’esperimento Stanford Gravity Probe B, un progetto da 750 milioni di dollari volto a testare la teoria della relatività generale di Einstein utilizzando giroscopi orbitanti. L’esperimento fu concepito nel 1959-60 e i lavori di progettazione iniziarono nel 1962. Le misurazioni furono effettuate nel 2004-05 e i dati analizzati vennero pubblicati nel 2011. Il lungo intervallo tra ideazione ed esecuzione è stato in parte dovuto al tempo necessario per sviluppare la tecnologia necessaria per le misurazioni, inclusa la produzione degli oggetti più rotondi al mondo: rotori giroscopici di quarzo così lisci che, se ingranditi alle dimensioni della Terra, la loro montagna più alta o la trincea più profonda non sarebbero più lunghe di due metri. La motivazione di tale levigatezza, secondo l’osservazione di Cartwright, è che le leggi della fisica impongono…
Il mondo scientifico inoltre, è responsabile di aver creato un’aura di negazione del tempo, privilegiando la fisica e la chimica come scienze esatte e atemporali. In fisica quantistica, il tempo potrebbe non esistere, mentre nella fisica galileiana il segno del tempo non cambia le equazioni. Einstein sosteneva che la distinzione tra passato, presente e futuro fosse solo un’illusione. La biologia e la geologia sono invece considerate inesatte e meno prestigiose. La biologia molecolare ha migliorato la sua immagine, ma la geologia rimane trascurata, senza premi Nobel e con un’immagine pubblica noiosa. Tuttavia, entrambe queste scienze hanno sempre riconosciuto l’importanza del Tempo Profondo. Una posizione che abbiamo incontrato nel libro della geologa Marcia Bjornerud recensito poco tempo fa.
Scritto in un caratteristico stile gradevole e pieno di intuizioni il libro è dedicato a criticare le ipotesi diffuse ma errate sulla scienza: che la scienza sia essenzialmente solo teoria più esperimento; che in un certo senso tutto ciò che la scienza ci dice è riducibile alla fisica; e che la scienza rivela che tutto ciò che accade, compresa l’azione umana, è determinato dalle leggi della fisica. Tanto per iniziare, è difficile capire perché si dovrebbe sostenere la terza immagine se non è convinti della seconda, che viene generalmente considerata il fondamento logico della terza.
La supposizione che la scienza equivalga a teoria più esperimento è, osserva l’Autrice, diffusa tra i profani così come tra scienziati e filosofi. Il tipo di teoria scientifica matematicamente esprimibile, familiare dalla fisica moderna e racchiuso in equazioni come F = ma, è considerato regola aurea. Da tali equazioni, si pensa, vengono previste specifiche conseguenze osservabili, e lo scopo della sperimentazione è quello di testare queste previsioni. E questo è fondamentalmente tutto. Tranne che, come mostra l’Autrice, non è così. Oltre alla teoria e alla sperimentazione ci sono modelli, narrazioni, diagrammi, illustrazioni, applicazioni concrete e così via. Nessuno di questi è riducibile alla teoria o all’esperimento, e non sono nemmeno meno essenziali per la pratica e il contenuto della scienza. E quando li prendiamo in considerazione, sia la scienza che il mondo che descrive sono visti come molto più complicati di quanto implichi la concezione comune della scienza e dei suoi risultati.
L’Autrice inizia la sua analisi notando che qualsiasi teoria è espressa in concetti e che la scienza mira a tali concetti con un contenuto sia inequivocabile che empirico. Come tutti i filosofi della scienza sanno, risulta essere molto difficile arrivare a un resoconto generale di come questo si raggiunga questo obiettivo. Prima di tutto, le definizioni esplicite di termini teorici sono ovviamente di scarso aiuto quando la definizione stessa è formulata in termini teorici ancora più avanzati. Ad un certo punto abbiamo bisogno di arrivare a termini con un chiaro contenuto empirico. Ma esattamente come funziona?
L‘operazionalismo sosteneva che la soluzione consisteva nel definire un concetto teorico in termini di un’operazione con cui lo scienziato potesse misurare il fenomeno empirico catturato dal concetto. Ma ci sono diversi motivi per cui questo non funzionerà. Per prima cosa, comporta analisi riduzioniste che possiamo indipendentemente sapere essere false. A titolo di esempio viene descritto il cosiddetto comportamentismo, che era un’applicazione dell’operazionalismo alla psicologia. Il comportamentista definirebbe la rabbia, ad esempio, in termini di comportamento osservabile sulla base del quale attribuiremmo la rabbia a qualcuno.
Si noti che l’implicazione dell’operazionalismo qui non è solo che possiamo sapere che qualcuno è arrabbiato osservando il suo comportamento. È che non c’è niente di più nella rabbia del comportamento. Ora, un problema con questa affermazione è che semplicemente non è vera. Una persona potrebbe essere arrabbiata senza mostrare i soliti segni comportamentali di rabbia, e potrebbe anche mostrare quei segni senza essere effettivamente arrabbiata. Quindi la rabbia è qualcosa di più del comportamento. Un altro problema è che risulta impossibile, anche a prescindere da ciò, è analizzare completamente la rabbia o qualsiasi altro stato mentale in termini interamente comportamentali. Supponiamo di dire che «Tizio è arrabbiato»: significa Tizio è disposto ad alzare la voce, aggrottare le sopracciglia, battere i piedi, e così via. Il guaio è che questa frase sarà vera solo se Tizio non desideri nascondere i suoi sentimenti. Ma se aggiungiamo alla nostra definizione un riferimento all’assenza di questo desiderio, ora abbiamo un ulteriore concetto mentalistico – il desiderio – che deve essere analizzato comportamentistamente. E si scopre che per effettuare una tale analisi, dobbiamo fare riferimento a ulteriori stati mentali, con quelli che ora necessitano di un’analisi comportamentista, e così via all’infinito. Di conseguenza, l’analisi operazionalistica non può essere effettivamente effettuata.
Un secondo problema con l’operazionalismo è che ha la falsa implicazione che non ci possono essere diversi test empirici per lo stesso concetto. Ancora una volta, l’operazionalismo sostiene che non c’è nulla di più in un concetto che l’operazione con cui ne testiamo l’applicazione. Quindi, se abbiamo due test diversi, dobbiamo avere a che fare con due concetti diversi. Ma è assurdo. Prendiamo, ad esempio, il concetto di essere rotondi. Posso verificare se qualcosa è rotondo guardandolo o sentendolo, e ovviamente è lo stesso concetto che sto applicando in entrambi i casi.
Un terzo problema, come sottolinea l’Autrice, è che nella pratica scientifica reale ci vuole spesso molto duro lavoro e argomentazione per dimostrare che un certo test empirico misura plausibilmente la realtà catturata da un certo concetto scientifico. Questo non potrebbe essere il caso se non ci fosse nulla di più nel concetto che il test empirico. Ne consegue che c’è di più nei concetti teorici di ciò che viene catturato da tali test, nel qual caso l’operazionalismo è falso.
L’empirismo logico, come nota l’Autrice, fu un altro tentativo fallito di risolvere il problema. La componente logica dell’empirismo logico aveva a che fare con la sua applicazione della logica formale moderna alla formulazione di teorie scientifiche, ad esempio come sistemi assiomatici da cui si potevano dedurre teoremi. La componente empirismo aveva a che fare con l’idea che le affermazioni di una teoria potessero essere verificate dall’osservazione. Anche qui ci sono diversi problemi.
Per prima cosa, cosa conta esattamente come osservazione? Solo ciò che può essere percepito dai nostri sensi? O contano le osservazioni fatte con gli strumenti? Inoltre, cos’è esattamente che stiamo osservando: oggetti fisici indipendenti dalla mente o dati sensoriali? E tutte le affermazioni scientifiche sono davvero verificabili in questo modo?
Si scopre che, proprio come il contenuto dei concetti teorici supera ciò che può essere catturato in una definizione operativa, così, più in generale, supera ciò che è osservabile. Il contenuto dei concetti è dato invece dagli assiomi della teoria in cui sono incorporati. Ma il problema ora, come nota l’Autrice, è che tali assiomi non sono mai sufficienti per determinare esattamente di cosa si tratta nel mondo empirico di una teoria. Consideriamo, di nuovo, l’equazione F = ma. Considerato da solo, non ci dice nulla di più che una quantità è uguale al prodotto di altre due. E come osserva Cartwright, questo è vero non solo per la forza, la massa e l’accelerazione di un oggetto materiale, ma anche per l’area di un rettangolo rispetto alla lunghezza dei suoi lati. Non c’è nulla nell’equazione stessa che ci dica quale di questi sia il suo oggetto: l’equazione portata ad esempio potrebbe benissimo rappresentare la formula per calcolare l’area di un rettangolo. Naturalmente, potremmo aggiungere ulteriori elementi al nostro insieme di assiomi, come la legge di gravitazione universale di Newton. Ma non importa quanti ne aggiungiamo, ci saranno sempre possibili interpretazioni alternative.
Naturalmente, in pratica, gli scienziati e i profani che hanno familiarità con il loro lavoro non si preoccupano di tali problemi. La ragione è che, per prima cosa, quando si incontrano un’equazione come F = ma, la maggior parte delle persone ha almeno in mente l’uso del linguaggio ordinario di termini come forza, massa e accelerazione, e quindi interpreta naturalmente le variabili alla luce di esse, anche se sanno che le variabili non sono destinate a corrispondere esattamente alle nostre nozioni di senso comune. D’altra parte, spesso applicano l’equazione come strumento per svolgere compiti molto pratici, come capire la velocità di una palla colpita da un tennista.
Ma tutto questo viene dall’esterno della teoria stessa, almeno se consideriamo la matematica da sola come ciò che è essenziale per la teoria in quanto tale. Inoltre, come sottolinea l’Autrice, questa utilità della teoria nelle applicazioni pratiche non implica che il mondo sia realmente esattamente come la teoria astratta lo rappresenta come essere. Come esempio noto viene riportata la teoria del flogisto, che è stata molto utile dal punto di vista predittivo e tecnologico nonostante il fatto che si sia poi scoperto che non esiste una cosa come il flogisto.
Si presume comunemente che la teoria scientifica ci dia una rappresentazione del mondo più ricca e accurata di quanto non faccia il senso comune, e in effetti dovrebbe sostituire la descrizione dei fenomeni basata sul senso comune. Ma come indica l’argomentazione dell’Autrice questo è il contrario della verità. Per prima cosa, la teoria scientifica, infatti, non può nemmeno essere interpretata in modo determinato senza una qualche connessione con l’uso linguistico ordinario da cui derivano in ultima analisi i suoi concetti, e con le applicazioni concrete a cui la teoria è destinata. D’altra parte, ciò che la teoria descrive sono in realtà solo caratteristiche astratte del mondo dell’esperienza comune, piuttosto che quel mondo in tutta la sua ricca complessità. Ciò non implica necessariamente che la teoria scientifica debba essere interpretata in modo strumentalistico piuttosto che realista. Ma supporta la visione realista strutturale epistemica secondo cui, mentre ciò che la teoria descrive è realmente presente in natura, è molto lontano dal catturare tutto ciò che è presente in natura.
Ora, a causa del modo in cui le applicazioni effettive di una teoria spesso determinano inconsciamente il modo in cui la interpretiamo, possiamo essere ciechi di fronte a quanto lavoro viene svolto dall’applicazione e quanto poco dalla teoria considerata isolatamente. In particolare, quando consideriamo una teoria isolatamente, solo in termini della sua formulazione matematica, i suoi concetti possono sembrare molto precisi. Ma un’applicazione concreta della teoria può comunque comportare un’interpretazione di quei concetti che non è così precisa. Eppure può comunque conservare la sua utilità, e mantenerla proprio perché i concetti vengono applicati in un modo che va oltre il contenuto della teoria stessa.
 La conseguenza di ciò è che gli scienziati spesso finiscono per supporre che la precisione sia possibile dove in realtà non lo è. Oppure, poiché l’applicazione di un concetto può essere suscettibile di precisione in un dominio limitato, gli scienziati possono erroneamente supporre che debba essere ugualmente capace di precisione quando esteso oltre quel dominio. Questo, sostiene l’Autrice, è particolarmente probabile nelle scienze sociali. Cita come esempio la nozione di probabilità. Quando consideriamo esempi semplici come estrarre carte da un mazzo equo, le probabilità di vari possibili risultati possono essere determinate con precisione. Ma ciò non significa che possiamo assegnare in modo significativo le probabilità agli eventi in generale, in ogni caso.
La conseguenza di ciò è che gli scienziati spesso finiscono per supporre che la precisione sia possibile dove in realtà non lo è. Oppure, poiché l’applicazione di un concetto può essere suscettibile di precisione in un dominio limitato, gli scienziati possono erroneamente supporre che debba essere ugualmente capace di precisione quando esteso oltre quel dominio. Questo, sostiene l’Autrice, è particolarmente probabile nelle scienze sociali. Cita come esempio la nozione di probabilità. Quando consideriamo esempi semplici come estrarre carte da un mazzo equo, le probabilità di vari possibili risultati possono essere determinate con precisione. Ma ciò non significa che possiamo assegnare in modo significativo le probabilità agli eventi in generale, in ogni caso.
In particolare, nota che le probabilità sono determinate in relazione a ciò che è stato definito come configurazioni casuali. Si tratta di circostanze in cui sia i possibili risultati che i processi che potrebbero portarvi possono essere pienamente specificati, e in cui ci sono probabilità incorporate nella situazione all’inizio da cui le probabilità che desideriamo calcolare cadono logicamente. Ancora una volta, estrarre carte da un mazzo equo sarebbe un esempio. Ma gran parte di ciò che accade in natura non equivale a una messa in scena casuale in questo senso. Ad esempio, nel mondo reale (al contrario di ciò che l’Autrice chiama le rappresentazioni del piccolo mondo di cui fanno uso gli scienziati sociali) spesso semplicemente non esiste un insieme relativamente semplice e fisso di variabili che potrebbero influenzare i possibili risultati.
In ogni caso, sia nelle scienze naturali che in quelle sociali, sostiene l’Autrice, la teoria è sempre e solo portata a pesare sul mondo attraverso vari intermediari. Prima di tutto, ci sono i modelli idealizzati con i quali facciamo in modo che astrazioni come le leggi della fisica influiscano sulla realtà concreta. Ad esempio, quando applichiamo le leggi di Newton al sistema solare, lo facciamo modellando quest’ultimo (in termini di un sistema di masse puntiformi che orbitano attorno a una massa puntiforme più grande, e così via). In questo modo, la nostra applicazione delle astrazioni è mediata da ulteriori astrazioni. Ci sono anche le narrazioni concrete attraverso le quali tutte queste astrazioni sono rese intelligibili. Pensate al modo in cui, per comprendere anche un sistema semplice come il sistema solare, dobbiamo ancora visualizzare grossolanamente oggetti di grandi dimensioni che si muovono nello spazio nel tempo intorno ad altri oggetti di grandi dimensioni; che, per comprendere le implicazioni della relatività speciale, raccontiamo storie di gemelli che viaggiano su razzi; e così via. Secondo l’Autrice anche diagrammi, grafici e illustrazioni influenzano profondamente il modo in cui interpretiamo e applichiamo la teoria. Né questi vari intermediari sono superflui. Semplicemente non potremmo capire o fare uso di teorie senza di esse.
Infine, anche la sperimentazione, sostiene Cartwright, è una questione molto più complessa di quanto non sia implicito nella nozione comune che scienza = teoria + esperimento. L’esperimento è spesso trattato come se il suo unico scopo fosse quello di testare la teoria. Ma non è così. A volte la sperimentazione viene condotta anche in assenza di una teoria ben elaborata, in un modo esplorativo che mira semplicemente a vedere cosa accadrà nelle varie circostanze. A volte la sperimentazione crea nuovi fenomeni che altrimenti non sarebbero osservati, dove, proprio perché non sono stati osservati altrimenti, non esiste ancora alcuna teoria che li spieghi. A volte la sperimentazione ricostruisce i fenomeni nel senso di alterare profondamente la nostra comprensione di essi, anche in assenza di considerazioni teoriche. E in tutti questi casi, la sperimentazione, come la teoria, dipende dalla fissazione del contenuto dei concetti, dei modelli, e così via.
Un altro luogo comune della moderna filosofia della scienza è che la teoria sia sottodeterminata dall’evidenza empirica. Ciò significa che per qualsiasi corpo di prove empiriche, ci sono sempre possibili teorie alternative che sono incompatibili tra loro ma coerenti con tali prove. Ciò non implica che tutte le teorie siano ugualmente buone, ma solo che considerazioni indipendenti sia dalla teoria che dall’evidenza empirica sono in ultima analisi necessarie per scegliere tra le teorie. Filosofi della scienza come Thomas Kuhn e Paul Feyerabend hanno anche mostrato come le considerazioni extra-scientifiche (di tipo filosofico, per esempio) svolgano un ruolo cruciale nel determinare l’esito della ricerca scientifica.
Le considerazioni sollevate dall’Autrice rafforzano notevolmente questi giudizi. In particolare, rafforzano la sottodeterminazione della teoria da parte dell’evidenza nella misura in cui non sono solo le teorie alternative ad essere compatibili con la stessa evidenza empirica. Ci sono anche i possibili modelli alternativi, narrazioni, diagrammi e via discorrendo che mediano tra teoria ed evidenza. E come per le teorie, così anche per i modelli, le narrazioni, i diagrammi, le considerazioni filosofiche non meno di quelle empiriche possono influenzare i nostri giudizi su ciò che rientra nella gamma delle opzioni rispettabili, su ciò che tutto sommato è plausibile.
Ciò non significa affatto che la scienza non sia un’impresa razionale, non più di quanto la filosofia non sia un’impresa razionale. Ciò che comporta, tuttavia, è che il confine tra scienza e filosofia è molto meno netto di quanto comunemente si supponga. Gran parte di ciò che oggi si presume sia scientifico – il rifiuto di approvare spiegazioni irriducibilmente teleologiche, la distinzione di qualità primaria/secondaria, e così via – sono in realtà solo ipotesi filosofiche controverse mascherate da risultati empirici. E non è possibile fare scienza senza fare ipotesi filosofiche di qualche tipo, che sono destinate ad essere controverse.
Nel film “L’esercito delle 12 scimmie” si dice «la scienza non è una scienza esatta». A dire il vero, c’è un’esattezza nei suoi aspetti puramente matematici, ma questo è precisamente perché le rappresentazioni matematiche semplicemente lasciano fuori tutti gli aspetti della realtà che non si adattano a quella esatta modalità di rappresentazione – che risulta essere parecchio. Non solo ci sono più cose in cielo e in terra di quelle sognate dagli scienziati, ma c’è anche più cose nella scienza stessa di quanto essi sognino. Argomento questo, parzialmente accennato in coda ad una passata recensione.
Nancy Cartwright

Considerata una delle più importanti filosofe della scienza viventi. Insegna alla University of California di San Diego e alla University of Durham in Inghilterra.
Considerata una delle più importanti filosofe della scienza viventi. Il suo lavoro si concentra sui rapporti tra scienza, società e politica, con un’attenzione particolare alle implicazioni etiche e pratiche della ricerca scientifica. Professoressa di Filosofia presso la Durham University e Distinguished Professor presso l’ Università della California, San Diego (UCSD) . Nella prima metà della sua carriera presso la Stanford University si è specializzata in filosofia delle scienze naturali, in particolare fisica; nella seconda metà, presso la London School of Economics e ora a Durham e UCSD, si è specializzata in filosofia e metodologia delle scienze sociali, con particolare attenzione all’economia. La sua attuale ricerca si concentra su oggettività e prove scientifiche, in particolare per politiche basate sull’evidenza.
Scienza, fiducia e verità
Rivolgersi alla scienza per trovare le risposte a dubbbi e incertezze. La scienza merita l’autorità che le attribuiamo? E la nostra fiducia ci aiuta, o la sfida e la critica sono motori di progresso migliori?
L’Universo a orologeria
The Guardian, 27 aprile 2021
Estratto dall’introduzione
1. Teoria + Esperimento non fanno una scienza. Non si tratta solo di teoria ed esperimenti. Tutti i prodotti della scienza giocano un ruolo fondamentale nel conseguimento dei suoi successi: modelli, misure, procedure e strumenti; sviluppo e convalida dei concetti; raccolta, analisi e cura dei dati; studi non sperimentali; tecniche statistiche; metodi di approssimazione; casi di studio; narrazioni e così via. E il loro complesso intreccio è altrettanto importante.
2. Spodestare la regina. Sappiamo tutti che “in realtà è tutto fisica” non è assolutamente vero. Tra l’altro, l’idea che tutto derivi dagli elementi costitutivi della “regina delle scienze” smentisce in linea di principio la varietà e la diversità sia della scienza sia della natura, e può portarci su strade di ricerca sbagliate. Per quanto riguarda l’unità, ci sono molti altri modi per raggiungerla che non siano quello di costruire tutto con i mattoni della fisica.
3. Una natura più negoziabile. Non è in alcun modo certo che i principi cui la scienza ricorre per produrre le sue meraviglie rappresentino delle “leggi di natura” che governano con mano ferrea. Spesso siamo noi a creare le circostanze giuste – li chiamerò piccoli mondi – dove nulla interviene a sconvolgere le condizioni iniziali, così che ciò che accade al loro interno sia fisso e prevedibile. A volte tali circostanze si verificano anche in natura, e allora quello che accade è davvero fisso e prevedibile, ma nella vita non funziona quasi mai così, e secondo me è sbagliato pensare che Dio o chi per lui abbia progettato l’intero mondo come uno strano e gigantesco orologio per dare un senso a quegli insiemi così precisi e rigorosi che osserviamo, o per farci capire perché a volte sia possibile trovarli o costruirli.
Nel luglio 2024 ho pubblicato tre post dedicati alla descrizione ed alla confutazione di altrettanti luoghi comuni sulla scienza.

