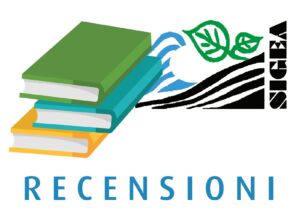
a cura di Giacomo Milazzo
Recensione
 Anche ai geologi occorrono medici! A parte gli scherzi questa rubrica racconta la scienza, e questo libro offre racconti davvero affascinanti.
Anche ai geologi occorrono medici! A parte gli scherzi questa rubrica racconta la scienza, e questo libro offre racconti davvero affascinanti.
Il mio medico mi disse una volta che dei tantissimi esami sostenuti per laurearsi probabilmente quello che più gli era piaciuto era “Storia della medicina”. Dopo aver letto questo libro non faccio fatica a credergli.
L’Autrice ci guida nel tempo e nelle storie di autoesperimenti e autosperimentatori, medici che hanno deciso di provare le proprie idee direttamente su loro stessi, spesso con un tocco di pazzia e di incoscienza, altre volte con sincero altruismo e cocciuto coraggio. Medici che, in molti casi, sono stati gli stessi che ha avuto l’intuizione e che hanno deciso di metterci il corpo per dimostrare di avere ragione. Talvolta il gesto non ha portato a risultati apprezzabili e si è perso nel nulla, qualcuno ci ha rimesso la pelle; in qualche caso ha spianato la strada a un premio Nobel e ha segnato un avanzamento fondamentale delle nostre conoscenze.
Il libro è ricco di dettagli e di storie interessanti, un libro molto denso in cui c’è veramente molto e quindi non è facile raccontarlo in breve né scegliendo un argomento piuttosto che un altro; gli argomenti inoltre possono essere seguiti a piacimento, non necessariamente in ordine di capitolo, creandosi una personale scaletta di interessi.
Le storie degli autoesperimenti appartengono quasi tutte al passato: cominciano tra Seicento e Settecento, si concentrano a cavallo tra Ottocento e Novecento e poi si diradano fino quasi a scomparire. Ma l’idea che c’è dietro è soprattutto quella che il bravo medico non deve fare agli altri ciò che non sarebbe disposto a fare su se stesso, ed è un’idea che ha senso ancora oggi: se si parla di ricerca, di rischio sanitario, di consenso informato, ma anche di terapie gravate da effetti collaterali importanti, i medici devono esser capaci di chiedersi cosa farebbero se fossero al posto della persona che hanno davanti, quanto si crede nella ricerca scientifica e che valore le si assegna rispetto alla propria ed all’altrui vita. Tutto ciò ovviamente, al netto delle aberrazioni della sperimentazione criminale perpetrata ad esempio nei campi di concentramento nazisti.
Il fatto che gli autoesperimenti diventino via via meno importanti nel corso del Novecento spiega perché l’etica e la filosofia medica se ne siano occupate così poco ma anche che nel tempo il modo di fare scienza e ricerca è cambiato: oggi, con un solo risultato sperimentale, non si fa molta strada e non è più tempo di scienziati solitari chiusi nel loro laboratorio a giocare con gli alambicchi.
D’altra parte, per ogni nuova medicina o per ogni nuova tecnica medica deve esserci pur stato un primo “fruitore”. Una scoperta deve essere provata su qualcuno per essere certi che funzioni. Ma perché sperimentare su di sé? La motivazione più alta è un generoso «non farei mai ad altri quello che non ho il coraggio di fare a me stesso». Ma a leggere le molte storie raccontate in questo libro si scopre che c’è anche chi l’ha fatto solo per comodità, o perché non veniva creduto da nessuno, o perché era semplicemente incapace di fidarsi di qualcun altro. Molti, poi, lo hanno fatto per pura curiosità, e alcuni persino per rabbia o per ripicca.
 Con penna ironica e leggera, l’Autrice tocca gli argomenti chiave del rapporto tra medicina, società e potere, coinvolgendo il lettore in alcune delle più incredibili storie della medicina, dal Seicento ai giorni nostri. Incontreremo medici che si fecero pungere intenzionalmente da zecche e zanzare per dimostrare l’origine di una malattia, spericolati inventori di rivoluzionarie tecniche chirurgiche, avventati sperimentatori di sostanze ignote e persino chirurghi che si auto-operano, per farsi pubblicità o perché privi di alternative. Sono vicende che non lasciano certo indifferenti, e nel loro complesso tracciano una storia della medicina decisamente diversa da quella che viene generalmente raccontata.
Con penna ironica e leggera, l’Autrice tocca gli argomenti chiave del rapporto tra medicina, società e potere, coinvolgendo il lettore in alcune delle più incredibili storie della medicina, dal Seicento ai giorni nostri. Incontreremo medici che si fecero pungere intenzionalmente da zecche e zanzare per dimostrare l’origine di una malattia, spericolati inventori di rivoluzionarie tecniche chirurgiche, avventati sperimentatori di sostanze ignote e persino chirurghi che si auto-operano, per farsi pubblicità o perché privi di alternative. Sono vicende che non lasciano certo indifferenti, e nel loro complesso tracciano una storia della medicina decisamente diversa da quella che viene generalmente raccontata.
In questa raccolta di storie e di scienziati e medici spericolati, e di sperimentazioni che oggi non sarebbero possibili, ripercorriamo eventi che hanno permesso di fare i progressi che hanno portato la medicina alla modernità.
L’Autrice accompagna quindi il lettore in un viaggio nella storia della medicina, tra storie incredibili e affascinanti o, a volte, inquietanti e sconvolgenti, come quelle che riguardano la ricerca degli anastetici migliori e che ha causato la tossicodipendenza in moltissimi medici che autosperimentavano gli effetti della cocaina o della morfina, compreso il celeberrimo Freud; o come quelle dei medici che si operavano da soli, persino quelli che, privi di anestesia, già nel Seicento si asportavano da soli calcoli enormi!
Tra il Seicento e la prima parte del Novecento l’autoesperimento è stata una pratica largamente diffusa, eticamente accetta e approvata dal punto di vista scientifico. Per comodità, curiosità, sfida, mancanza di alternative o per diventare il nome stampato sui libri di storia, scienziati e medici hanno usato questo approccio per sperimentare tecniche chirurgiche mai pensate prima, valutare gli effetti di farmaci e altre sostanze, indagare come funzionano le infezioni e scoprire nuove malattie. Se oggi la scienza si basa su studi clinici svolti secondo parametri precisi e rigorosi, e sul coinvolgimento di un numero congruo di persone per raggiungere un certo livello di standardizzazione, non molto tempo fa i dati venivano raccolti tramite l’osservazione di casi singoli, o poco più, nella migliore delle ipotesi.
Quale modello migliore per la ricerca medica se non l’essere umano stesso? Fino al secondo dopoguerra, l’autoesperimento era comune e spesso efficace, con molti sperimentatori che usavano se stessi come soggetti. Anche la letteratura ha tratto ispirazione da questi episodi, come nel romanzo “Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde”, basato su un autoesperimento di trasformazione.
Che sia per sincero altruismo o per amor di scienza la scelta di procedere con strani esperimenti sul proprio corpo è stata prassi normale: dal primo cateterismo cardiaco alle diete improbabile per identificare i nutrienti fondamentali, dal farsi pungere intenzionalmente da varie specie infestanti (zecche e pidocchi, per dirne un paio) all’autoappendicectomia, dal cocktail a base di colera alla scoperta della sostanza psichedelica LSD.
In diversi casi, questi esperimenti non hanno prodotto i risultati sperati; in altri, hanno confermato l’ipotesi di partenza, mentre a volte hanno sovvertito teorie precedentemente accettate. Alcuni scienziati hanno compromesso la propria carriera, e talvolta la propria vita, mentre altri hanno ricevuto il Nobel. Le storie narrate sono ricche di dettagli – curiosi, particolari e talvolta all’apparenza addirittura improbabili – sulla vita e sulle prodezze medico-scientifiche di questi medici audaci e intraprendenti che, grazie al loro spirito di iniziativa, hanno contribuito significativamente all’avanzamento della medicina. Il linguaggio utilizzato è ricco e incisivo, accessibile al grande pubblico, e una lieve ironia rende la lettura ancora più gradevole.
Dal Seicento ai giorni nostri la pratica dell’autoesperimento ha attraversato un periodo glorioso, seguito come si è scritto dal progressivo abbandono, ma non è del tutto finito. Qualche medico dichiara di voler esaminare la pratica dell’autoesperimento e dimostrare che è ancora accettabile. Soprattutto alla luce dei successi delle nuove tecnologie di editing genetico (CRISPR/Cas) e ancorché rarissimi, ci sono casi di scienziati che hanno provato su di loro una terapia genica per allungarsi la vita, che attualmente risulta molto lontana dal dimostrare la sua efficacia. Uno addirittura, un biofisico noto e molto discusso per le sue attività scientifiche da garage, nel 2017 si è editato da solo i propri geni ed ora vuole rendere l’ingegneria genetica una pratica alla portata di tutti.
L’ultimo capitolo, il biohacking, sembra essere l’ultima frontiera dell’autosperimentazione, destinato probabilmente a chiudersi anche se, incredibile ma vero, il dark web è ricchissimo di istruzioni fai da te!
In un’intervista l’Autrice racconta infine come e perché abbia deciso di raccontarci queste storie. Per rispondere a quel certo grado di fastidio che genera il modo comune con cui viene raccontata la medicina, con l’immagine stereotipata e preponderante nella classe medica del vecchio pensionato che scrive la storia ora di questo, ora di quel padre di questa o quella scoperta, salvo scoprire in realtà che questa figura retorica del «padre» è molto spesso contestabile.
Anche nel lontano passato non c’è mai stato il genio che da solo fa la grande scoperta, e un attimo dopo il mondo cambia. Ci sono sempre state persone che facevano ricerca sulle stesse cose in posti diversi. Così come dibattiti, scambi di idee, liti e discussioni, e soprattutto il periodo giusto con le persone giuste, con la scoperta che in qualche modo…era nell’aria.
Quindi quando sentiamo dire di tizio o caio che sono i padri di questa o quella disciplina si scopre sempre che magari a due passi il padre di quella stessa materia è un altro. Persino nei casi in cui va riconosciuta l’unicità o la genialità (che so, Galileo, Einstein…) c’era dibattito, condivisione, confronto, e qualcuno che stava per concludere le stesse cose su qualcosa.
I vari padri da soli difficilmente possono partorire alcunché. E giocando con la metafora delle madri, le uniche che partoriscono davvero, nella scienza nessuno ne ha mai parlato, nemmeno quando sarebbe stato facile.
E, non a caso, questo libro dimostra, ancora una volta, come le donne siano, nella storia della scienza, le grandi assenti. Mosche bianche. Per colpa degli uomini, nemmeno a dirlo.
L’Autrice racconta quindi una medicina per come è andata davvero la storia, una medicina cioè che cambia nel tempo, che viene guidata da idee e filosofie che hanno una grande permeabilità col resto della società e che cambiano soprattutto nelle situazioni contingenti, nell’emergenza, quando emerge qualcosa di nuovo o quando qualcuno si accorge di qualcosa di nuovo; l’Autrice in definitiva ci restituisce un’immagine della medicina in cui difficilmente da un giorno all’altro si cambia idea, dove è improbabile se non impossibile che possano esistere grandissime scoperte istantanee ma dove invece ci sono ricercatori e scienziati che discutono, che bisticciano e sbagliano, che si confrontano nei congressi. Che ad ogni risposta ottenuta seguono dozzine di nuove domande e dubbi: che fanno scienza.
Silvia Bencivelli

Silvia Bencivelli si laurea in medicina e chirurgia all’Università di Pisa nel 2002. Nel 2004 ottiene il master in comunicazione della scienza alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste. Nel 2005 inizia a collaborare con il quotidiano scientifico di Rai Radio 3, Radio3 scienza, di cui diviene uno dei conduttori. Oggi è tra i conduttori della rassegna stampa culturale di Rai Radio3, Pagina3. Per Rai Radio3 ha curato, scritto e condotto diverse serie speciali, come il Dizionavirus Archiviato il 15 gennaio 2021 in Internet Archive. e il Lessico Vaccinale Archiviato l’8 ottobre 2021 in Internet Archive. e come il ciclo di Vite che non sono la tua dedicato agli intellettuali in fuga durante il fascismo e La rivoluzione della salute universale, dedicato alla nascita del Servizio sanitario nazionale. Ha scritto e condotto numerose puntate di Wikiradio – Le voci della storia.Collabora con quotidiani e riviste, tra cui la Repubblica, D di Repubblica ed il Venerdì, Le Scienze, Mente e cervello, Focus, Wired. Ha scritto per Il manifesto, per la pagina mensile di Chips and Salsa dedicata alla scienza nell’inserto culturale Alias, e con La Stampa, per l’inserto Tuttogreen. Come giornalista scientifica, ha esordito presso la sede romana dell’agenzia Zadig, lavorando con Romeo Bassoli.È docente di giornalismo scientifico al Master su “La scienza nella Pratica Giornalistica” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

